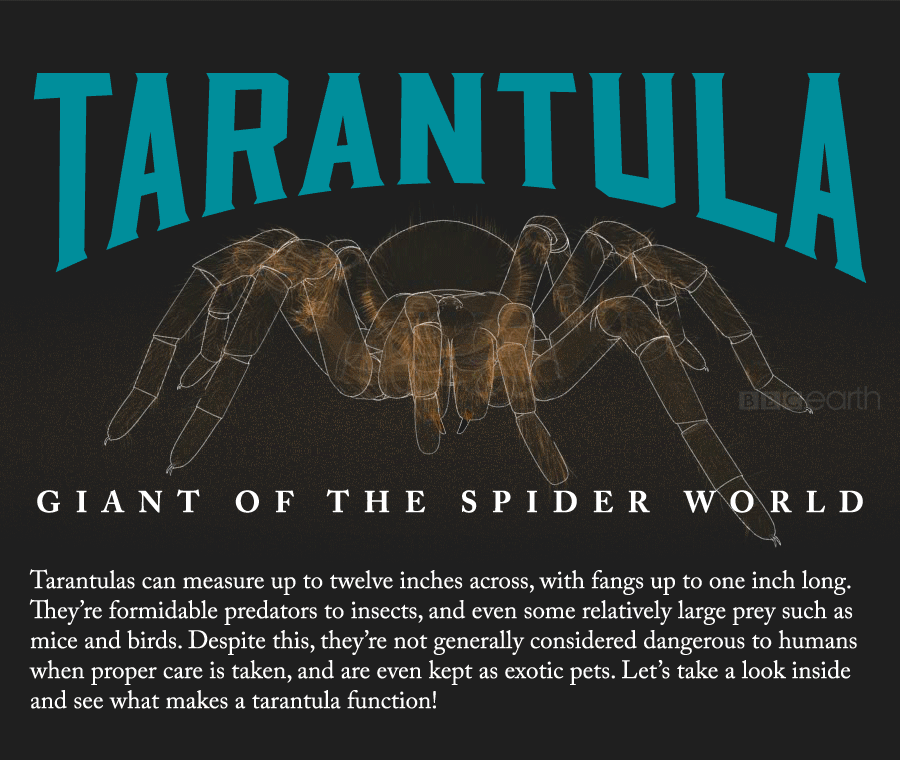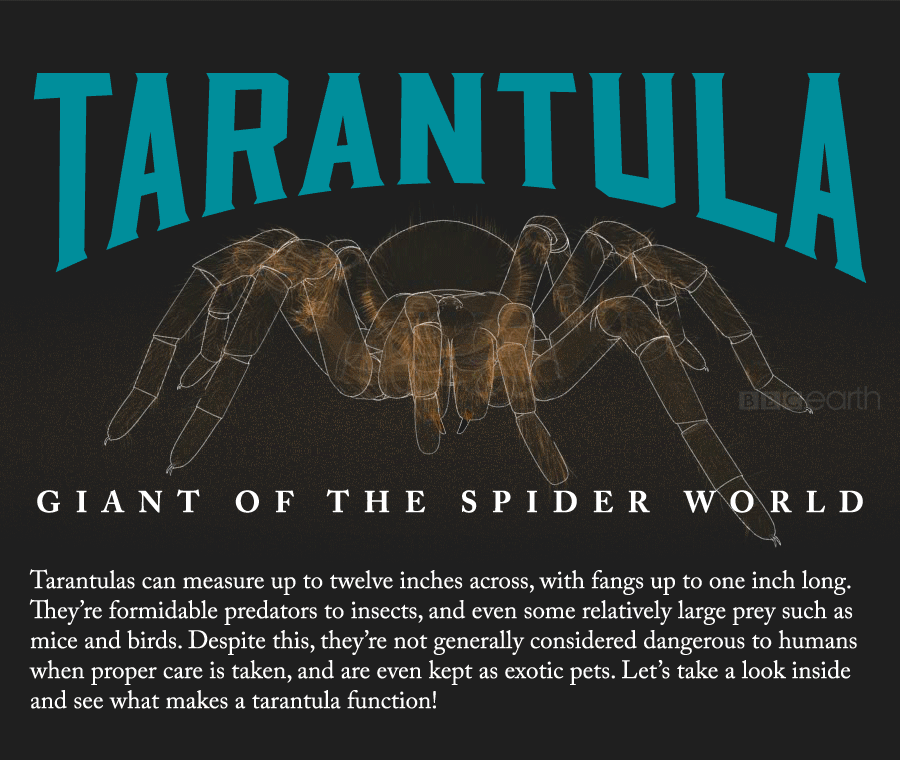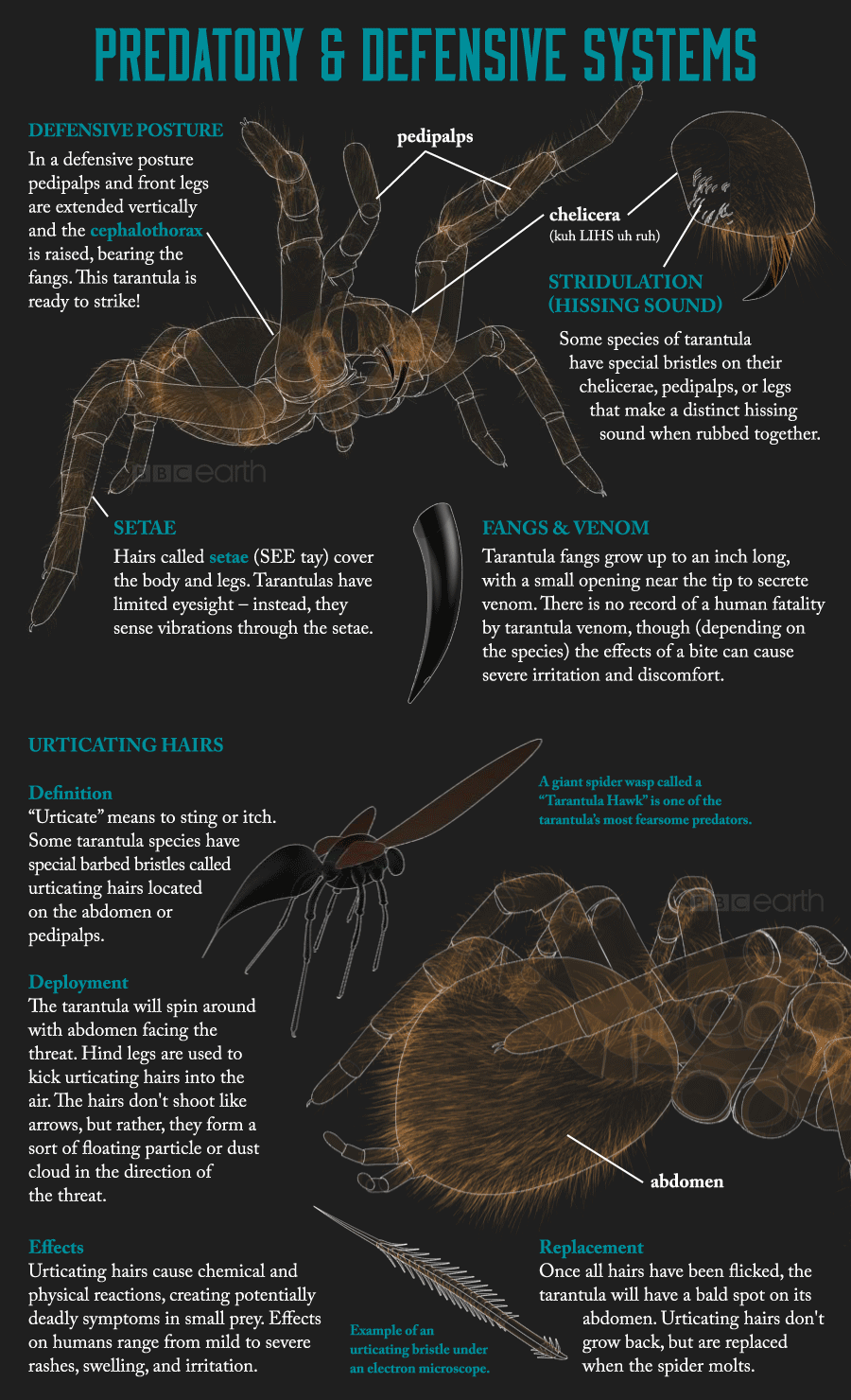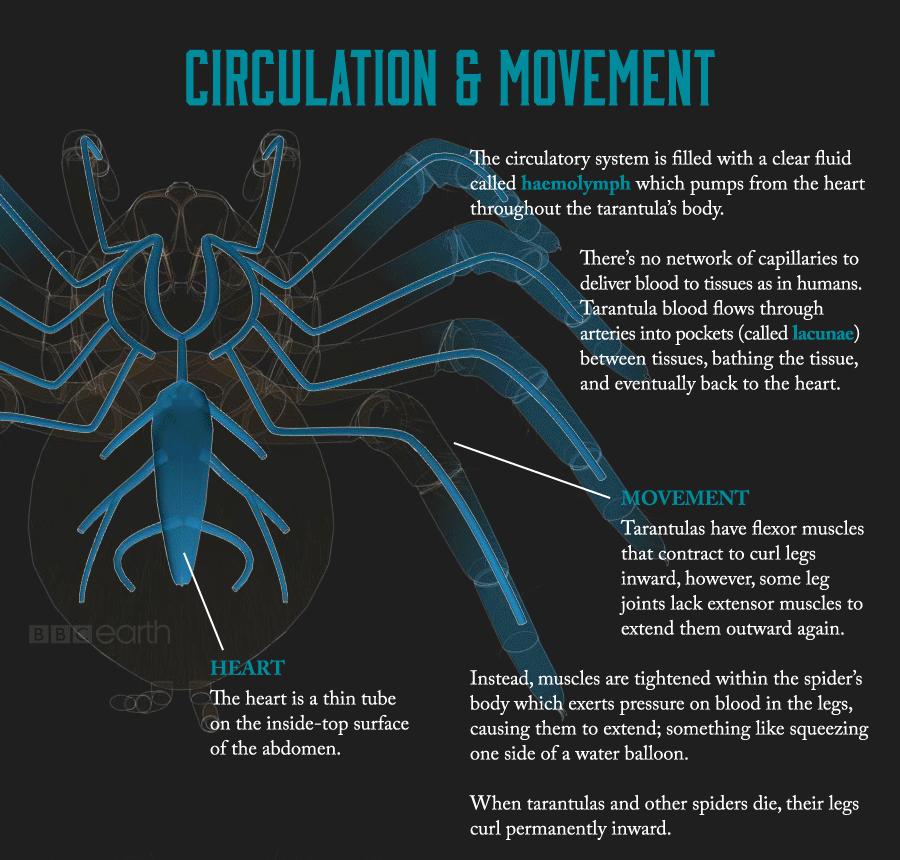Questo articolo è stato letto 1 1,387 volte
Le tarantole appartengono all’ordine degli aracnidi e possono misurare fino a 30 centimetri di diametro, con le zanne lunghe fino a 3 cm. Sono formidabili predatori di insetti e altre prede relativamente grandi come topi e uccelli.
Nonostante questo, non sono generalmente considerati pericolosi per l’uomo e alcune persone li adottano come animali domestici esotici.
Ma come funziona una tarantola? Diamo uno sguardo all’interno di questo prodigio della natura, aiutandoci con delle bellissime gif animate.
Sistemi di attacco e di difesa
Di fronte agli occhi partono due appendici chiamate cheliceri che terminano con gli aculei veleniferi. Questi, oltre a servire per immobilizzare le prede vengono anche usati per scavare o spostare piccoli oggetti (per esempio il sacco ovigero).
I cheliceri sono costituiti da un segmento basale e da uno terminale a forma di artiglio o di zanna. Caratteristica unica fra i chelicerati è la parte terminale dei cheliceri, la punta della zanna, che viene adoperata per inoculare il veleno secreto dalla ghiandole velenifere.
All’esterno dei cheliceri si trovano i pedipalpi, appendici dall’aspetto quasi identico alle zampe, ma con un segmento in meno. I pedipalpi vengono usati durante l’alimentazione e come strumenti tattili, nei maschi questi acquistano anche la funzione di organi sessuali secondari.
In posizione di combattimento, la tarantola porta i pedipalpi in alto, per difendersi da eventuali attacchi e contemporaneamente lasciare campo libero ad un’offensiva coi cheliceri
Dopo i pedipalpi troviamo quattro paia di zampe, suddivise in sette segmenti: coxa, trocantere, femore, patella, tibia (con sperone tibiale nei maschi di molte specie), metatarso etarso.
È una questione di peli
Oltre ai normali peli sul corpo, alcune tarantole di origine americana hanno anche dei peli urticanti (circa 10.000 per mm²). Oltre a lanciarli contro i possibili aggressori, i peli urticanti vengono usati per marcare il territorio: venendo strappati con le appendici posteriori, formano una scia ai bordi della tana, scoraggiando così eventuali predatori, specie durante la muta.
In base al tipo di nemico i peli possono dimostrarsi mortali oppure un semplice deterrente. Nelle persone gli effetti si limitano ad un prurito nella zona colpita, mentre risultano ben più pericolosi per i piccoli predatori che infastidiscono il ragno.
Alcune specie, come Citharischius crawshayi, posseggono peli stridulanti che se strofinati gli permettono di creare un forte rumore in modo da scoraggiare eventuali assalitori.
Alimentazione e digestione
Come abbiamo già detto, col morso il veleno passa dalle ghiandole velenifere attraverso i cheliceri e viene iniettato nel corpo della preda, che viene paralizzata.
Le ghiandole sono costituite in genere da una parte epiteliale con e sono avvolte da un rivestimento le cui contrazioni consentono lo sgorgare di goccioline di veleno all’interno dei cheliceri fino alla base delle zanne. Alla base hanno delle gnathocoxae usate come mascelle per tenere ben stretto il cibo, coadiuvarne la triturazione, la liquefazione e infine l’assimilazione.
Hanno un intestino alquanto stretto, che può ricevere solo cibo in forma liquida, e due serie di filtri appositi per trattenere all’esterno qualsiasi particella di cibo solido, per quanto piccola. Essi utilizzano, uno alla volta, due sistemi diversi per digerire il cibo esternamente prima di ingerirlo.
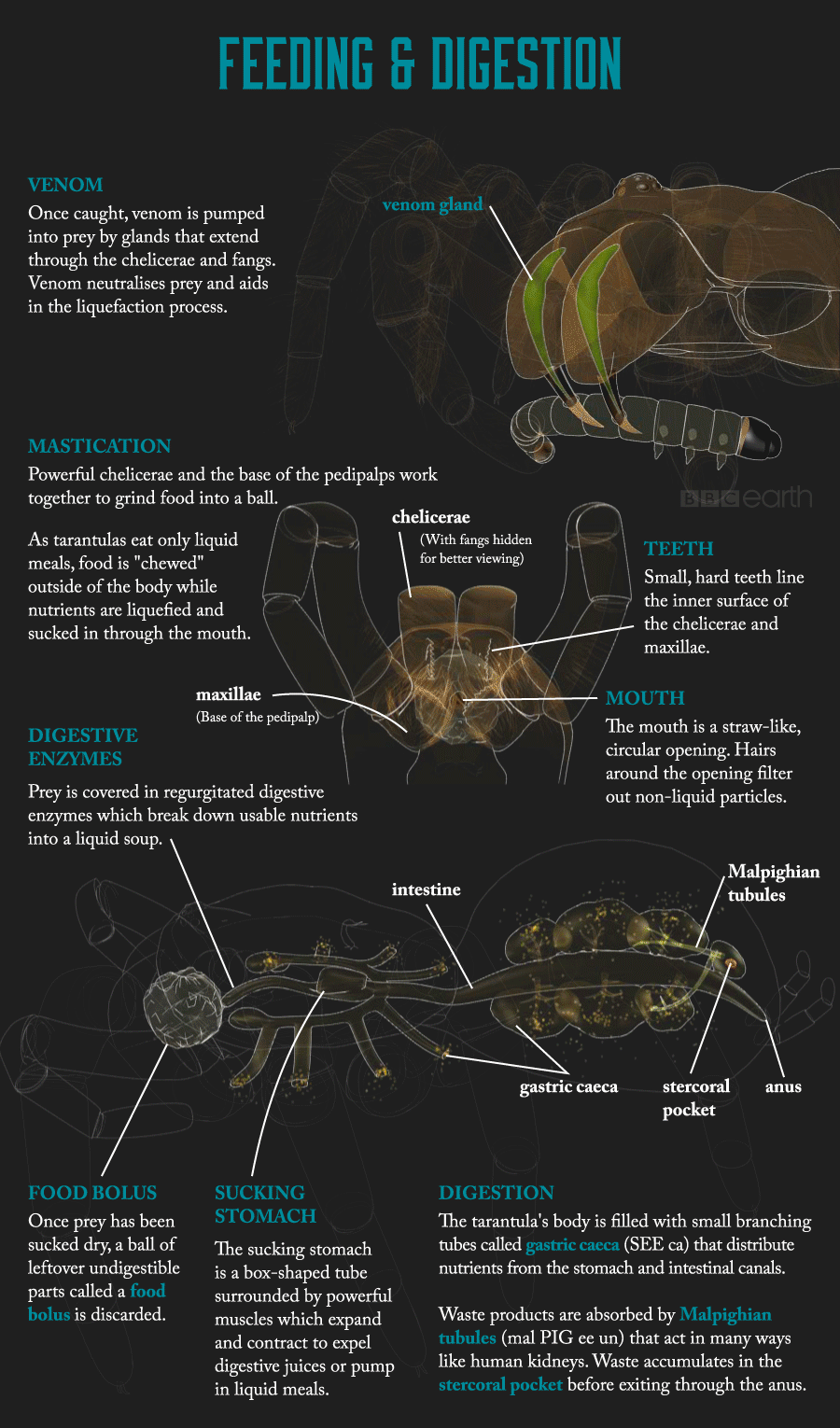
Apparato circolatorio, zampe e movimento
Il sistema circolatorio funziona con un liquido chiaro chiamato emolinfa ed entra nel cuore dall’emocele, scorre lungo gli ostii in un’unica direzione, entra nell’aorta anteriore, che passa attraverso il pedicello ed entra ad irrorare il cefalotorace distribuendosi nel seno periviscerale e apportando nutrienti essenziali. Dall’altro lato del cuore parte dell’emolinfa si incanala nell’aorta posteriore ed in arterie periferiche che hanno il compito di portare nutrienti all’opistosoma attraverso un altro seno periviscerale.
Ossigenate le due estremità, il sangue del ragno affluisce nei polmoni a libro, in particolare nel seno polmonare che li avvolge, dove viene di nuovo ossigenato e, attraverso una piccola vena detta vena pneumopericardica, passa di nuovo nel cuore a chiudere il sistema circolatorio aperto degli aracnidi.
La tarantola ha dei muscoli flessibili atti alla contrazione delle zampe, ma per muoversi non usa il sistema muscolare bensì quello circolatorio descritto sopra. La parte ventrale del cefalotorace è detta sternum e si collega al carapace e alle coxa, tramite un diaframma morbido chiamato pleura che permette reciproci movimenti.
Image via: animagraffs.com