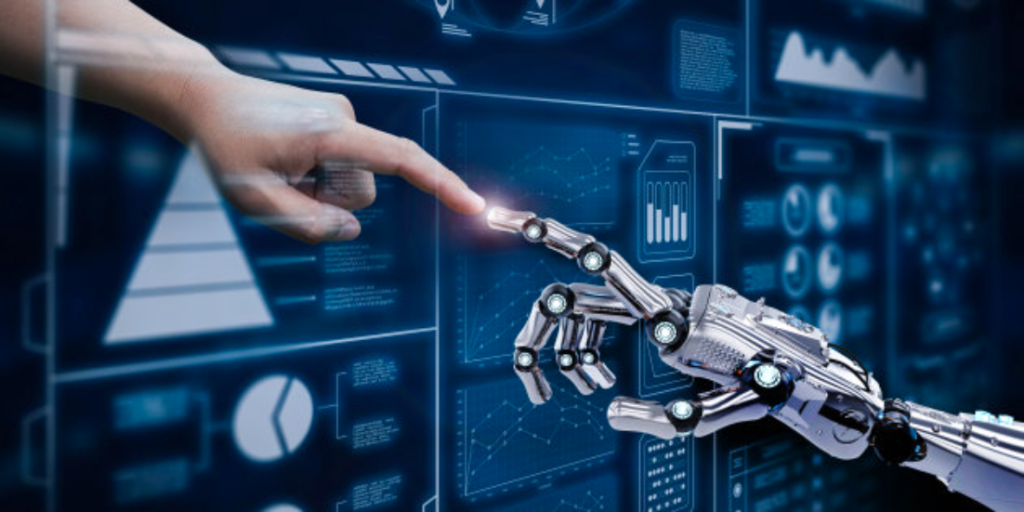Questo articolo è stato letto 1 575 volte
Capacità che un tempo erano considerate esclusive dell’intuizione umana oggi sono replicabili dai computer grazie all’intelligenza artificiale, e questo fa paura.
Copernico, Darwin e Freud: uomini rivoluzionari che hanno cambiato la concezione che l’uomo ha di se stesso.
Oggi, a secoli di distanza, siamo alle soglie di una nuova rivoluzione, che implica un concetto del tutto nuovo: l’uomo non è più qualcosa di diverso da una macchina, ha perso la sua unicità, ora abbiamo l’intelligenza artificiale, in grado non solo di replicare le capacità dell’uomo, ma addirittura di superarle.
Basti pensare al riconoscimento facciale, la guida automatica e tante altre applicazioni che un tempo erano considerate troppo difficili da realizzare per la logica della programmazione, ma che oggi sono possibili addestrando una rete neurale che in poche ore impara da sola.
Le capacità che un tempo erano considerate esclusive dell’intuizione umana oggi sono replicabili dai computer grazie alle reti neurali, e questo fa paura.
È possibile educare all’intelligenza artificiale?
Punto focale di dibattiti etici, morali e politici, l’intelligenza artificiale è diventata ormai parte della nostra vita, e volenti o nolenti dobbiamo farci i conti. Siamo in un’era in cui la distanza tra uomo e macchina si è notevolmente assottigliata, e si pone quindi la necessità di essere “educati”, con l’accezione di formati, all’intelligenza artificiale. Ma cosa vuol dire essere educati all’intelligenza artificiale? Da cui il titolo dell’articolo e del convegno EduIA, e soprattutto: “è possibile educare all’intelligenza artificiale”?
Il quesito, posto da Francesco Agrusti, Gianmarco Bonavolontà e Mauro Mezzini, organizzatori dell’evento tenutosi il 15 novembre (non a caso proprio presso le aule della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre) s’interroga circa la possibilità di offrire una formazione interdisciplinare all’intelligenza artificiale.

A rispondere sono state chiamate importanti personalità dell’ambito scientifico.
- Renato Spigler, professore ordinario di Analisi Numerica presso l’Università di Roma Tre, che con il suo discorso d’apertura ci invita a riflettere riguardo al cambiamento che è già in atto;
- Luciano Floridi, professore ordinario all’Università di Oxford che ha offerto un interessante punto di vista attraverso le sue teorie riguardanti la filosofia dell’informazione e l’etica informatica;
- Roberto Navigli, professore ordinario nel Dipartimento di Informatica presso l’Università La Sapienza di Roma, nonché creatore di BabelNet, il più grande dizionario computazionale enciclopedico multilingue, vincitore nel 2015 del premio META (Multilingual Europe Technology Alliance), che ha illustrato la possibilità di creare una semantica a partire da qualsiasi tipo di testo, indipendentemente dalla grammatica e dalla sintassi;
- Mario De Caro, professore ordinario di Filosofia morale all’Università Roma Tre che con il suo intervento ha sottolineato quanto la teorizzazione morale riguardante l’intelligenza artificiale in Italia sia indietro rispetto al resto del Mondo, e quanto sia profondamente sbagliato asserire che l’etica sia un’esclusiva del genere umano, e inapplicabile alle macchine;
- Carla Limongelli, professore associato presso l’Università di Roma Tre al Dipartimento di Ingegneria, ha fatto luce sul concetto di oggetto didattico, e di come siano possibili le compenetrazioni con l’intelligence artificiale;
- Fabio Ciotti ricercatore TI all’Università di Roma Tor Vergata, che con il suo intervento ha approfondito diversi aspetti e tematiche delle Digital Humanities, sia dal punto di vista teorico e metodologico sia da quello sperimentale e applicativo;
- Teresa Numerico, professore associato in Logica e filosofia della scienza dell’Università Roma Tre, che ha illustrato le tematiche legate alla filosofia dell’informatica e dell’intelligenza artificiale e della tecnologia della comunicazione.
A conclusione dell’evento gli organizzatori hanno esposto il loro progetto basato sulle reti neurali convolutive applicate all’elaborazione di dati in grado di prevedere l’abbandono degli studi da parte degli universitari.
Intelligenza artificiale: farmaco o veleno?
Sebbene provenissero ognuno ad un campo didattico ben distinto, il trait d’union è stato proprio l’intelligenza artificiale, con le sue molteplici implicazioni e utilizzi possibili. Al termine della giornata si può dire che il risultato auspicato sia stato raggiunto, ma non solo: è andato ben oltre. Perché oltre a fornire chiavi di lettura da diversi punti di vista, i relatori hanno posto ulteriori domande sull’argomento focale della giornata, spingendo gli interlocutori a chiedersi: l’intelligenza artificiale rappresenta per noi il farmaco o il veleno?
Ma perché la scelta di questo ossimoro? In greco la parola phàrmakon ha in sé un duplice significato: essa vuol dire cura ma anche veleno, e in questo caso la metafora con il tema del giorno appare quasi doverosa. Le macchine ci aiuteranno a risolvere i nostri problemi quotidiani, o prenderanno il nostro posto nel Mondo, togliendoci il lavoro e impigrendo il nostro sistema cognitivo? Essere a conoscenza dell’esistenza di una macchina in grado di svolgere un qualsiasi compito meglio di noi, ci ha tolto la spinta a dare il massimo, a migliorarci?
E ancora: quanto possiamo fidarci degli algoritmi insiti nella creazione delle reti neurali? Non dimentichiamoci che sono pur sempre macchine, e per loro stessa accezione di significato create dall’uomo: sono davvero così imparziali? O risentono dei pregiudizi dei loro creatori? Queste e tante altre questioni sono rimaste in sospeso, e ci hanno dato lo spunto per ragionare su un argomento davvero spinoso, che ha cambiato, e sta tuttora cambiando la nostra visione delle cose in quanto genere umano, ma ci sta anche insegnando un nuovo linguaggio: quello delle macchine. 
È possibile educare all’intelligenza artificiale?
Tornando al quesito iniziale: è possibile educare all’intelligenza artificiale? La risposta che nel mio piccolo sento di dare è sì: ma soltanto attraverso una nuova tipologia di educazione e formazione, non più focalizzata in maniera univoca ed esclusiva verso un solo ramo del sapere, ma una conoscenza di tipo trasversale che abbracci quante più opportunità di applicazione possibile, in modo tale da poter trovare un posto anche per l’uomo in un mondo in cui la conoscenza specialistica sarà probabilmente esclusiva delle macchine.
Un futuro distopico? Forse, ma ricordiamoci che al momento l’intelligenza artificiale ha i suoi limiti, che ben presto, come abbiamo avuto modo di vedere, saranno superati. E’ insito nella programmazione delle macchine che tanto amiamo e temiamo: l’automiglioramento, ogni giorno di più, e quando capiranno che non devono simulare l’uomo, ma emularlo, quando cominceranno a creare opere d’arte equiparabili alla Gioconda, allora avremo la certezza che la quarta rivoluzione è iniziata.
[amazon_link asins=’B0792HCFTG,B079PPQJWP,8871925939,B07681S2RK,B01DFK1HU8,8850333978,8871922298′ template=’ProductCarousel’ store=’mentedigitale-21′ marketplace=’IT’ link_id=’36ef20c8-f550-11e8-b4af-fd999c5733ac’]